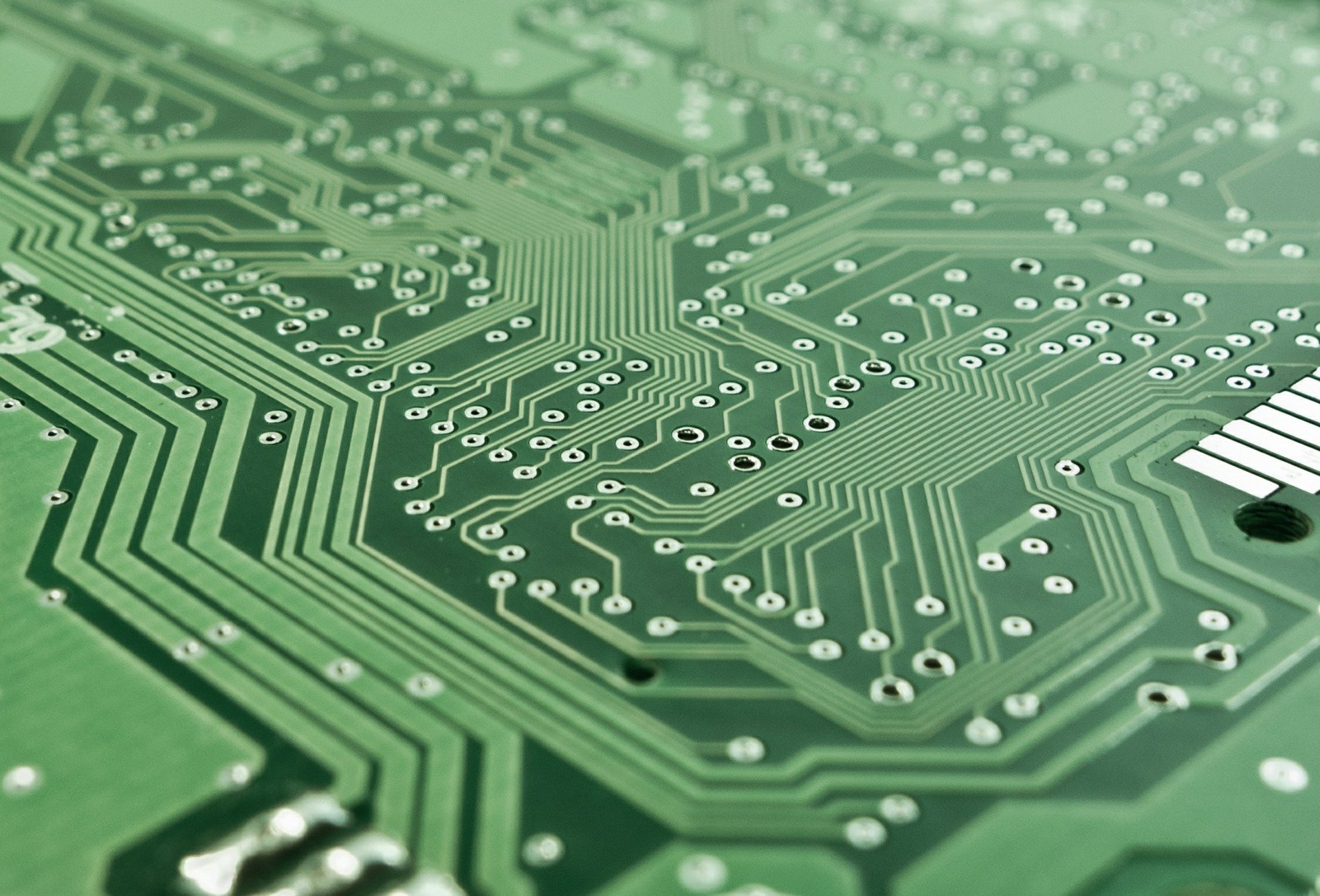Durante il periodo estivo ci sono meno attività quotidiane da svolgere. Rimane così un po’ più tempo per pensare a come migliorare i processi lavorativi e un po’ più tempo per la formazione e l’informazione. Mi sono così imbattuto in un articolo di un quotidiano nazionale, uno di quelli che stanno in cima alle vendite, che sono comunque sempre più scarse per tutti. Parla, questo articolo, di ILVA e nello specifico della situazione precaria e della poca chiarezza rispetto al suo futuro. Lo fa dando voce alle preoccupazioni dei sindacati.
Fin qui non vedo motivo per cui io possa avere qualcosa di interessante e originale da dire, però il titolo dice altro: parla anche di “microchip nella tuta“.
La cosa allora si fa interessante: per storia lavorativa di tecnologia IT e di “microchip” ne so qualcosa. Vediamo allora se posso imparare altro. Leggo bene tutto l’articolo e scopro che c’è una sigla sindacale che ritiene che ci sia il rischio che i lavoratori vengano tracciati e monitorati con dei microchip inseriti nelle divise di lavoro. Intuisco che si stia parlando di TAG RFid. Questa tecnologia, l’RFid, non è un’invenzione diabolica di qualche intelligenza maligna che vuole dominare e controllare il mondo, anzi, è piuttosto datata e abbastanza diffusa. Si tratta di un, per semplicità chiamiamolo ancora così, microchip che può essere letto a distanza tramite delle antenne. La distanza di lettura varia in funzione del tipo stesso. Può andare alcuni metri, come può essere nel Telepass dell’auto, a pochi centimetri, come può essere in un badge per accedere al posto di lavoro e “timbrare”. Quindi, anche senza metterlo nelle tute all’ILVA, questo “famigerato” microchip ce lo portiamo addosso tutti i giorni. E’ usato ad esempio anche negli abbonamenti dei mezzi di trasporto o per accedere agli impianti di risalita delle piste di sci o anche per viaggiare in traghetto a Venezia. Ancor di più, a questo punto, risulta meno chiaro perché questo articolo mi ha colpito.
Un paio di cose mi sono sembrate da subito degne di interesse, ma poi lasciando passare qualche giorno sono arrivato a tre. Un articolo di poche righe con tre cose interessanti è raro e merita un approfondimento.
La tecnologia aiuta anche nelle attività più banali.
Il “microchip”, prima o poi smetto di chiamarlo così visto che so esattamente cos’è (ma non voglio rinunciare completamente all’elemento comunicativo che mi ha attratto nella lettura), è nelle tute perché queste vengono lavate dall’azienda e restituite pulite al lavoratore. L’utilità sta nel fatto che il processo di restituzione della propria tuta al legittimo proprietario è automatizzabile e il numero di errori, scambio di indumenti tra lavoratori, diventa estremamente basso. Con oltre 10.000 dipendenti direi che è una eccellente idea, comoda per il lavoratore che ha sempre la sua tuta e comoda per l’azienda che riesce a spuntare dalla lavanderia un prezzo inferiore per il lavaggio. Si direbbe un processo “WIN-WIN”: tutti ne beneficiano.
Nonostante sia un’eccellente idea, non è assolutamente una novità assoluta perché molte lavanderie industriali, che servono comunità in cui ci sono indumenti da rendere esattamente al proprietario come in associazioni, case di riposo o caserme, usano questa tecnica. A me pareva normale, ma del resto è più o meno il mio lavoro. Ma il motivo per cui se ne scriveva qui era un altro.
La tecnologia fa paura (ogni tanto però)
La sigla sindacale, immagino in rappresentanza di alcuni lavoratori preoccupati, che ha emesso il comunicato stampa ripreso dal giornalista, non ha ritenuto che fosse buona cosa. Teme infatti che i lavoratori vengano così controllati a distanza con uno strumento invisibile e quindi ancor più orribile: il “microchip”.
Cosa si poteva fare allora prima di prendere una posizione? Magari chiedere all’azienda che forse aveva già spiegato tutto, oppure nel dubbio verificare, chiedendo a qualcuno che ne capisse qualcosa (evitando Facebook o l’amico “tecnico esperto”): come dicevo, si tratta di qualcosa che esiste da tempo, facilmente identificabile da qualcuno che ne sa. Nella fattispecie la risposta sarebbe stata che la lettura dei dati può avvenire solo a distanza brevissima e usando particolari antenne. Quindi, basandomi sulle informazioni che ho (poche), e con la mia esperienza (di più) direi che non ci sono pericoli.
Ma se volessi veramente tracciare una persona in uno spazio lavorativo, avrei bisogno di un “microchip”? Direi proprio che non mi serve. Le tracce di ciò che portiamo con noi spesso sono sufficienti. Il badge per timbrare, ad esempio, altro non è che una variante del TAG (basta microchip, se siete arrivati fin qui evidentemente la lettura è adeguatamente attrattiva di suo) che starebbe negli indumenti. Chi lo porta indosso è teoricamente (ma è praticamente impossibile) tracciabile come nel caso dei vestiti. Di solito però, oltre che dei vestiti, quando siamo al lavoro non ci priviamo mai del nostro “amato” smartphone, che per inciso in alcuni casi usa una tecnologia, l’NFC, che è parente stretto del microchip (ci sono cascato di nuovo!). Oltre a quello, molto più facili da leggere, il dispositivo emette una serie di segnali radio, bluetooth, WI-FI, rete cellulare, che sono molto comodi da seguire (se uno volesse). Se dobbiamo preoccuparci della nostra privacy e della nostra riservatezza, preoccupiamoci sempre.
L’ignoranza fa paura (quando facciamo senza esserci informati adeguatamente)
L’ignoranza in questo caso non è intesa in senso spregiativo: si intende semplicemente mancanza di conoscenza adeguata. I problemi che genera quando condiziona le nostre decisioni “non informate” sono facilmente ovviabili. O non si prendono decisioni (quando si può), o le si lascia prendere a chi ne sa (meglio verificare che non si tratti di un altro ignorante travestito da informato), oppure la migliore: ci si informa e si impara. Imparare, soprattutto se non si è obbligati, è spesso un’attività piacevole. Chi sono gli ignoranti (sempre in senso benevolo) in questa vicenda: di sicuro il sindacato che ha sollevato la questione. Il lavoratore rappresentato da quella sigla probabilmente è anche lui ignaro della questione, ma del resto è anche per questo che ha delegato la rappresentanza a chi, o ne sa di più o ha il compito di informarsi.
Mi sono accorto però che c’è un altro ignorante nella storia (sempre in senso benevolo), ed è chi ha scritto l’articolo: il giornalista. Dal mio punto di vista questo è un po’ più pericoloso: per noi, per lui e alla fine anche per l’editore.
Adesso “piscio fuori dal vaso”
Prima di scegliere questo titolo al capoverso ho controlla “su internet” e ho scoperto che questa frase la usano anche i giornali veri. Mi permetto di farlo perché io sono tra i pochi che ancora oggi in Italia legge i giornali. Non solo sbirciando quello che gratuitamente viene messo nei loro siti web (cosa già buona), ma pure pagando 3, dicasi 3, abbonamenti (ovviamente digitali). Mi rendo conto che così sballo le medie dei lettori italiani, ma mi piace l’informazione di qualità. In questa maniera, pago per non essere costretto a informarmi su Facebook. Penso di guadagnarci, perché penso che l’informazione proposta e approfondita da un professionista esperto abbia un valore che va riconosciuto economicamente.
Però…
Però poi questa deve essere fatta bene, fatta da qualcuno che non è ignorante come me sull’argomento, perché se lo è deve avere modo di informarsi prima, con un collega, con un network di esperti “veri”, tenendosi aggiornato. Cosa ho pensato del lavoro di questo giornalista dopo aver letto il suo articolo? Ho pensato che avesse preso il comunicato stampa del sindacato, l’avesse scritto in maniera corretta ed interessante (anche questa è un’abilità per cui pago i giornali e una parte dei libri che leggo) e basta.
Se fossi stato interessato all’ILVA sono certo che “sgugolando” (neologismo che indica la ricerca su Google) avrei trovato da solo il comunicato e me la sarei letto. Sicuramente la prosa ne avrebbe risentito (giuristi, commercialisti e sindacalisti non sono noti per avere un modo di scrivere particolarmente fluido). Se fossi tecnologico, e lo sono, userei tranquillamente un aggregatore di notizie.
Invece leggo i giornali.
Però voglio che chi scrive faccia per me le verifiche. Perché dell’errore sul “microchip” mi accorgo da solo, ma ogni volta che mi rendo conto di superficialità e inesattezze riguardo a temi che conosco mi sorge il dubbio di essermi “bevuto” un sacco di altre informazioni incomplete, superficiali o errate in ambiti in cui l’aiuto mi sarebbe più necessario. Dicevo prima che l’ignoranza è pericolosa per me, lettore e per il giornalista perché senza professionalità è dura rimanere al proprio posto e crescere, e per l’editore. Se il prodotto che vende non è in termini di affidabilità e qualità diverso da un blog anonimo, da un social network, o anche dal lavoro automatico di un aggregatore di notizie, io il giornale non sono più disposto a pagarlo. E ne sarei dispiaciuto.
Mi fermo: il vaso è pieno, se lo faccio tracimare il risultato sarebbe molto sgradevole.